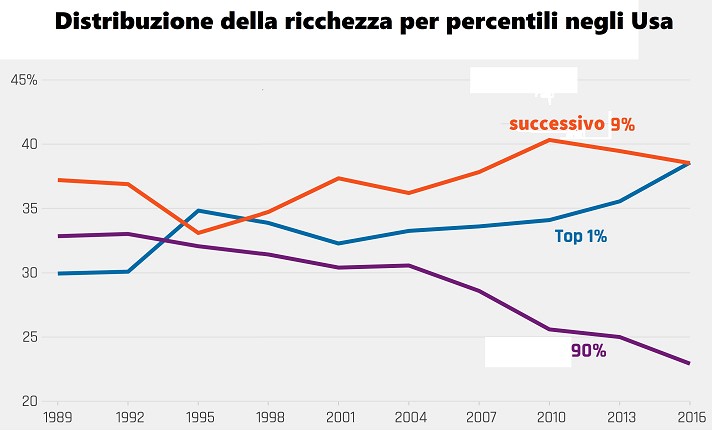In tutto il mondo è in atto un attacco, di forza e dimensioni
inedite, alla dimensione rurale, ma - in prospettiva -
anche
quelle stesse componenti agroindustriali che apparivano parte
subalterna del sistema egemonizzato dalle multinazionali.
Sotto
la spinta, incentivata dalla pandemia, al "nuovo ordine
mondiale", al
great reset, la triste sorte, in passato riservata ai contadini,
alle
comunità rurali, al piccolo commercio e all'artigianato, viene
prefigurata anche per chi pareva avere le spalle grosse, per le
filiere
che parevano ben inserite nel main stream, non solo economico e
politico ma anche ideologico. Ancora oggi vediamo componenti del
mondo
agricolo difendere, come fosse una propria risorsa vitale,
quella
chimica che le tiene legate a un sistema di multinazionali che
sta
pianificando un futuro post-agricolo. Di fronte a uno scenario
inedito,
anche gli interessi rurali devono ridefinire strategie e
alleanze.
Cruciale è il rapporto agricoltura-ruralità, un rapporto in gran
parte
spezzato con l'adesione agricola al produttivismo di marca
industriale,
con le campagne ridotte a lande desolate livellate al laser e a
deserti
di biodiversità con le monocolture, con l'affermarsi di una
separazione
netta tra produzione agricola, residenza e svolgimento di altre
attività (caccia, pesca, turismo, sport). C'è spazio, di fronte
a
minacce sempre più gravi e incombenti, per una ricomposizione,
almeno
parziale, della frattura tra ruralità e agricoltura? Per la
ricomposizione tra mondo agricolo e attività venatoria (ma anche
con le
raccolte di frutti spontanei, l'equitazione, la pesca sportiva,
le
attività ricreative nello spazio rurale)? Il ritorno a un
nuovo
ruralismo (da non confondere con il neo-ruralismo di matrice
urbana)
presuppone, non solo da parte della componente agricola ma anche
delle
altre categorie che fuiscono dello spazio rurale, di
atteggiamenti
nuovi, di maggiore corresponsabilità, in primis la
consapevolezza che,
operando in una logica di conflittualità reciproca, al di fuori
di
strategie e valori comuni, tutti saranno sconfitti.
In tutto il mondo è in atto un attacco, di forza e
dimensioni inedite, alla dimensione rurale. Esso è sferrato
congiuntamente (al di là delle apparenze) da un
animal-ambientalismo
che ha assunto il ruolo di una religione (con i suoi dogmi, i suoi
profeti, i suoi sacerdoti, i suoi "eletti") e dalle
multinazionali.
Così come l'animal-ambientalismo, anche il capitalismo delle
multinazionali ha rafforzato enormemente il suo potere. E intende
farlo
valere. L'immenso potere conferito dal controllo di internet (in
prospettiva sempre più "delle cose") e delle nuove tecnologie
informatiche (A.I.), si aggiunge a quello già acquisito con la
chimica,
le biotecnologie, l'agroindustria, la grande distribuzione. Non a
caso
i big del web, dotati di risorse finanziarie e di potere politico
enormi, stanno investendo nella produzione alimentare e nelle reti
di
distribuzione. Nelle ultime classifiche dei 10 uomini più
ricchi al mondo 6 hanno a che fare con internet e l'informatica, 2
con
Google.
In nome della "salvezza del pianeta", usando l'arma della paura,
del
senso di colpa, del "peccato ecologico", prospettando scenari
apocalittici (solo ipotetici), i nuovi chierici millenaristi, e i
loro
sponsor ultramiliardari, vogliono tenere sotto controllo le masse
con il
monopolio del cibo e gli occhi informatici del grande fratello,
eliminare i ceti medi e ogni attività economica indipendente,
abolire
la (piccola e media) proprietà privata, concentrare l'umanità
nelle
megalopoli e farle tirare la cinghia mangiando insetti e "mangimi"
artificiali. Rispetto allo stadio precedente del capitalismo, che
presupponeva una maggiore distribuzione del reddito per alimentare
il
consumismo, in quello attuale i profitti prosperano anche con una
crescente concentrazione del reddito e della ricchezza. Il
consumismo diventa meno necessario per il ciclo capitalistico e
quindi non c'è bisogno di distribuire reddito come in passato.
Queste
tendenze, avviate negli anni '80 del secolo scorso, con le
politiche
neo liberali, continuano nel nuovo secolo, in Europa solo meno
accentuate che negli Usa ai quali si riferiscono i dati seguenti.
 Fonte
Fonte
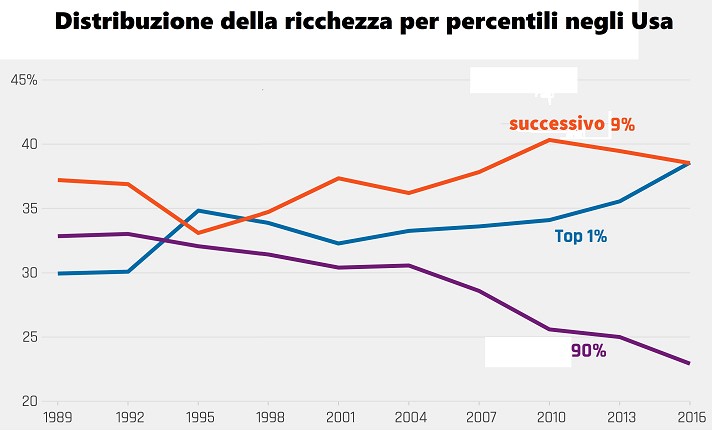 Fonte
Fonte
Sostituire l'agricoltura con la wilderness e il cibo artificiale
è
la logica ed ovvia premessa di questo programma ed è qui che le
due ali
marcianti del "nuovo ordine mondiale", l'animal-ambientalismo e
l'iper-capitalismo, trovano la loro perfetta saldatura:
l'agricoltura e
l'allevamento inquinano - dicono gli animal-ambientalisti - che,
in
attesa di una "transizione" che riporti l'umanità a pochi milioni
di
esseri umani o che preveda la trasmigrazione su altri pianeti (la
"terra promessa"?), accolgono con entusiasmo i cibi artificiali e
la
pseudo agricoltura senza terra (le vertical farm, del tutto
antiecologiche, di cui abbiamo parlato nel post precedente, qui).

Cosa c'è di nuovo in questo scenario? Dal nostro punto di vista
una
cosa fondamentale: l'agricoltura industrializzata, che nella
precedente
fase del capitalismo aveva assunto un ruolo di "reparto esterno"
dell'industria, ad essa del tutto subordinata (la componente di
valore
aggiunto agricola della filiera agroalimentare può rappresentare
anche
solo il 2%) oggi tende ad essere annullata, azzerata. La
produzione di
cibo viene "disaccoppiata" dalla terra. A fare le spese di questa
tendenza non è solo la componente agricola basata
sull'allevamento, ma
anche - già oggi - la produzione vegetale. Il favore accordato
dall'Unione Europea ai prodotti vegetali che simulano quelli
animali
(magra consolazione l'aver ottenuto solo di impedire le diciture
"latte
di ...") non deve consentire ai coltivatori di nutrire eccessive
speranze. Innanzitutto perché le multinazionali del cibo
artificiale
coltivano direttamente i prodotti vegetali da essi utilizzati o li
acquistano da altre multinazionali e comunque da determinate aree
del
mondo dove è attuata un'agricoltura fortemente industrializzata.
Sino a
che le materie prime saranno sostituite da altre ottenute senza
terra o
senza neppure coltivare piante. La criminalizzazione già in atto
del vino non dovrebbe lasciare tranquilli i viticoltori.

Un nuovo puritanesimo per indurre alla
penitenza alimentare
Per imporre quelle trasformazioni, che dovrebbero condurre al
pieno
controllo della produzione alimentare da parte delle
multinazionali,
esautorando l'agricoltura, si fa leva su un nuovo puritanesimo, un
nuovo spirito di mortificazione e di autoflagellazione. Due sono
gli
ambiti dei sensi di colpa: quello dietetico-nutrizionale e quello
dell'impronta di carbonio. Il peccato non è più offesa a Dio e al
prossimo, non è più disordine morale (che, anzi, ogni richiamo
alla
famiglia e alla morale tradizionali sono condannati come eresia
dalla
nuova Inquisizione) ma è l'offesa a Gea, al pianeta contro
il
quale pecchiamo con eccessive e inutili emissioni di CO2 e offesa
al
dieticamente corretto. Cosa faccia bene o male alla salute ci
pensa il
grande fratello a stabilirlo. Così, per un consumatore reputato
eterno
bamboccio (che è meglio non impari mai a leggere le etichette), ci
sono i semafori nutrizionali a indicare cosa è buono e
giusto cosa no. Adottati dalla Nestlè, sin dal 2019, saranno
introdotti
obbligatoriamente dal grande fratello di Bruxelles. Il latte
finto, di
piselli (2,2% di proteine di qualità biologica inferiore a
quelle
del latte) è largamente artificiale. Per "assomigliare" al latte
la multinazionale di Vevey deve aggiungere fosfato tricalcico, vit
B2 e B12 e D. Ma queste
operazioni non potranno mai compensare le centinaia di molecole
bioattive del latte (presenti, meglio chiarirlo subito,
maggiormente - in alcuni casi
esclusivamente -, nel latte di ruminanti alimentati con foraggi
freschi e
buon fieno). Il finto latte della Nestlè sarà però benedetto e
avrà uno
"score A", superiore al latte vero. Ma solo perché la
scienza
nutrizionistica rimane ancorata al paradigma riduzionistico che
non
attribuisce valore alle proprietà nutraceutiche (al confine tra
alimento e farmaco), alle componenti non ancora completamente
messe a
fuoco ma di cui si conoscono le proprietà, a un approccio
grossolano
che si sposa perfettamente con quello dell'industria
alimentare.
Vino, formaggi stagionati e salumi saranno classificati cibi al
penultimo stadio di qualità dietetica, un solo gradino più in alto
delle
merendine spazzatura con i loro oli idrogenati, emulsionanti,
conservanti, anti-ossidanti, coloranti, zeppe di chimica. Tutto
ciò
riflette la forza delle lobby multinazionali che, oltre che sulle
istituzioni politiche, hanno molti modi per influenzare anche
quelle
mediche e scientifiche.
 Il
non
latte della Nestlè (intanto c'è scritto milk)
Il
non
latte della Nestlè (intanto c'è scritto milk)
La nuova morale prevede che ogni desiderio e ogni perversione
siano
lecite, siano un "diritto" inalienabile, poi, però, intende
regolare la vita quotidiana
come mai nessuna dittatura è riuscita ad attuare.. e non parliamo
di
diritto alla privacy, in un mondo del capitalismo della
sorveglianza
che ti spia ovunque. Dalla sua, il grande fratello ha gli
strumenti
tecnologici che consentono non solo di spiare ma anche di
controllare
in modo attivo quello che facciamo e di privarci di ogni libertà
di
scelta. Pensiamo ai frigoriferi connessi, alle bottiglie connesse.
Superata una certa dose di calorie o di grammi di alcool
giornalieri il
frigo non si aprirà, le bottiglie non erogheranno il loro
contenuto
(ovviamente non sarà lecito "nascondere" cibo e alcoolici e
detenerli
in modalità che sfuggano al controllo). Il grande fratello si
preoccupa
(dice lui) della nostra salute e della salute del pianeta,
vuole
tenerci a stecchetto per il bene nostro e delle generazioni a
venire e concederci solo mezzo bicchiere di vino
annacquato, mezzo bicchiere di latte di piselli, una manciata di
farina
di tarme, qualche foglia di insalatina cresciuta alla luce dei led
in
idroponica. Gli schiavi dell'antichità stavano meglio perché per
non rovinare il capitale i padroni li alimentavano abbastanza
bene. Non parliamo delle bistecche, peccato mortale (in un
contesto dove peccato e inferno sono dichiarati dalla chiesa ex
cattolica concetti "superati"). È il trionfo dei novelli puritani,
dell'ascetismo coatto, dei nuovi Girolamo Savonarola, degli
"eletti"
che si senton0 in diritto di mortificare, sadicamente, il
prossimo.

Il capitalismo "sostenibile" vuole
distruggere l'industria
lattiero-casearia
La Nestlè, con il suo Wunda, non lancia proclami
vegan-ambientalisti, crociate contro le produzioni animali come,
vedremo oltre, fanno altri. Non
potrebbe farlo, considerata la sua storia. Punta al profitto
offrendo,
come sempre nella storia dell'industria alimentare, nuovi prodotti
che
rispondono a una domanda di novità da parte di un consumatore
sprovveduto, disposto a pagare caro l'assemblaggio di materie
prime
low-cost, oggetto di nuove modalità di trasformazione,
manipolazione,
e ricombinazione e... il fattore modaiolo, cui pensano i media
(appendice del sistema tecno-industrial-finanziario. Nestlè nasce
nel 1866
con il latte in polvere, ampliando poi l'attività produttiva al
cioccolato al latte e al
latte condensato. Se, oggi, il finto latte farà chiudere stalle e
latterie non sarà una novità. I prodotti Nestlè hanno soppiantato
il
latte materno sulla base di indicazioni mediche "igieniste" che
sono
state nel tempo sconfessate, sino alla recente "riabilitazione"
dell'allatamento al seno (da non riabilitare, invece, generazioni
di
pediatri che prendevano soldi dall'industria). Ma, oltre a privare
del
latte materno generazioni di bimbi in tutto il mondo, Nestlè, con
il suo
latte in polvere e condensato (un "lunga conservazione" in
anticipo
dell'era UHT) ha anche dirottato il consumatore dal
consumare latte
fresco delle latterie e stalle "a km 0".

Non ha la storia della Nestlè, invece, la rampante Oatly che
proclama apertis
verbis: «Il nostro obiettivo è distruggere una delle più grandi
industrie del mondo – quella della produzione del latte – e nel
processo aprire una nuova strada per il sistema alimentare», ha
scritto
Toni Petersson, amministratore delegato di Oatly, prima della
quotazione al Nasdaq. Il tenore delle campagne pubblicitarie della
società è altrettanto aggressivo. Per operare il salto, da
una piccola
azienda che operava in Svezia a una società quotata a Wall Street,
Oatly è ricorsa alla società leader di investimenti
Blackstone,
del miliardario Stephen Schwarzman. Blackstone è responsabile,
attraverso due società brasiliane (Hidrovias do Brasil e
Pátria
Investimentos) della deforestazione dell'Amazzonia.
Blackstone possiede
la maggioranza di Hidrovias mentre Pátria è
possedura per più del 50%
da Hidrovias e, per un 10%, dalla stessa Blackstone.

Queste società di logistica operano il trasporto della soia e del
grano con immense chiatte. Esse muovono dal nuovo terminal
fluviale di Mirituba, collocati su
un affluente del Rio delle Amazzoni, nello stato del Paranà. Il
terminal è gestito da Hidrovias e può operare grazie
alla nuova
autostrada M-163 che le società controllate da Blackstone hanno
contribuito, attraverso il reperimento di capitali, ad asfaltare e
gestire l'infrastruttura. La gravità di tutto questo è legata al
fatto
che il "bacino" di produzione agricola (soia e grano) creato dalla
M-163 è l'unica area del Brasile (dove, nel complesso, le foreste
stanno
riguadagnando terreno) che vede avanzare la deforestazione. Il
volume dei cereali e della soia trasportati attraverso la nuova
infrastruttura (centinaia di milioni di tonnellate) giustifica le
accuse. Impossibile negare il ruolo, almeno indiretto, di
Blackstone nella deforestazione. Ecco allora che Oatly, che punta
su
consumatori vegan per moda, o comuque convinti di fare scelte
positive
per la propria esclusiva salute, ma anche su consumatori
"consapevoli", che credono
che la "consumare finto latte salvi il pianeta, ha dovuto
arrampicarsi
sugli specchi per spiegare ai propri fan e clienti la giustezza
della scelta di
farsi finanziare da Blackstone (qui)(lettura
divertente e istruttiva).
 Una
chiatta
di Hidrovias che trasporta la soia ai porti marittimi
verso le
destinazioni global
Una
chiatta
di Hidrovias che trasporta la soia ai porti marittimi
verso le
destinazioni global
A parte il solito macchiavellismo ("il fine giustifica i mezzi"),
che nella storia ha giustificato i peggiori orrori (vedi
Hiroschima),
Oatly azzarda contorte argomentazioni. Quella che (per loro)
dovrebbe risultare la più convincente si basa sull'astruso
concetto che, offrendo al "cattivo capitalista" un'occasione di
elevati
profitti, costui sarà indotto a disinvestire
dai business "sporchi". Ma la logica del capitalismo spinge ad
allargare all'infinito la "circolazione del capitale" di marxiana
memoria. Le strampalate argomentazioni di Oatly presuppongono che
i
business "verdi" diano sempre alti rendimenti, quelli "sporchi"
meno,
che il business "buono" sia capace di offrire indefinite
possibilità di
investimento. Aria fritta.

La natura strategica dell'attacco ai
sistemi di produzione animale
Il
caso
Oatly è, dal nostro punto di vista, altamente illuminante. Da
una parte il business del finto latte non solo non nasconde ma,
anzi,
proclama, come un grido di guerra, di voler combattere l'industria
lattiero-casearia "tradizionale" causa di una buona parte (secondo
loro) dell'effetto serra (tanto da sospettare che ci si trovi di
fronte al classico capro espiatorio). Dietro questi proclami
ideologici c'è
la spregiudicatezza di un business senza scrupoli, che non si pone
problemi etici ad essere finanziato da chi finanzia la
deforestazione
amazzonica. Esso intende far leva su consumatori influenzati dalla
propaganda delle organizzazioni ambientaliste che, con i loro
anatemi,
le loro profezie apocalittiche, le loro benedizioni e
ecoindulgenze (sono o non sono la nuova chiesa e la nuova
religione legittimati, oltre tutto, da una chiesa allo sbando?)
agiscono direttamente per favorire determinati interessi
capitalistici (anche a scapito di altri, meno forti e
spregiudicati).
Basti pensare a certe campagne sulla soia "sostenibile" o sulle
"energie rinnovabili". Gli ambientalisti, del resto,
ricevono
finanziamenti dalle multinazionali e praticano lo scambio
reciproco di
cadreghe (nei board di amministrazione). Per gli economisti, nelle
loro
fredde ma a volte lucide visioni, le organizzazioni ambientaliste
rappresentano una
industry, come le altre, una componente organica del sistema del
capitalismo delle big corporation, con i suoi fatturati e i suoi
business
plan, con i suoi manager, intercambiabili con altre companies. Ma,
proprio perché c'è questo nesso
organico tra ambientalismo e business, va preso sul serio il
grido di guerra di Oatly. Proprio perché è strumentale, proprio
perché
è spregiudicato, proprio perché è solo una strategia di profitto
esso è pericoloso. Si tratta di un business che, per
crescere, necessita di alimentare una campagna aggressiva contro i
prodotti animali, miscelando affari e ideologia (un'ideologia che
assomiglia sempre più maledettamente a una nuova religione di
stato). La campagna contro le produzioni animali, in cui si
distinguono anche i politici nostrani (vedi il "nostro" ministro
della "transizione ecologica") non
avrebbe la forza che sta mostrando se con corrispondesse a
interessi strategici del
capitalismo delle multinazionali. Dopo aver ridotto la componente
agricola delle filiere a misera cosa (con il latte a 37 cent da
noi e
25 in Lituania) la prospettiva di sostituire in larga misura le
filiere
lattiero-casearie con i prodotti artificiali è molto alletante per
garantire profitti durevoli.

Un aspetto che è bene tenere presente è che, rispetto alle
filiere
di produzione dei cereali e della soia, quelle zootecniche, almeno
in
Europa, continuano a essere basate su aziende che, tranne le
debite eccezioni,
sono a dimensione famigliare. Basti pensare che, ancora nel 2016,
in Olanda,
paese all'avanguardia zootecnica, erano più le vacche da
latte allevate in piccole stalle con 50-100 capi che quelle
presenti nelle stalle più
grosse e che, in Italia, sempre nel 2016, solo il 22% delle vacche
da latte erano allevate
in stalle con più di 100 capi. La strada per un controllo più
stretto
da parte delle multinazionali della produzione di alimenti passa
quindi
più facilmente per la sostituzione dei prodotti animali con
"sostituti" di origine
vegetale. Scordatevi la contabilità da ragionieri (spesso astrusa
e contestabile) della CO2, vi sono in ballo poste ben più
concrete. Nel caso della produzione delle materie prime
vegetali vi
sono molti
meno limiti al controllo della produzione di vaste superfici, alla
sostituzione di prodotto di una provenienza con quella di un'altra
area, al trasferimento rapido di risorse (l'industria del latte ha
tempi lenti, condizionati da quelli biologici della riproduzione e
sviluppo animale).
Un sistema interconnesso e
interdipendente che assimila
l'agricoltura all'industria per poi... scaricarla
Se è vero che, dietro i finti latti, ci sono business
strettamente
intrecciati con sistemi di finanziamento, produzioni agricoli,
trasporti altamente insostenibili (direttamente nel caso della
soia,
indirettamente in quello del "latte" di avena), non si può
dimenticare
che, oggi, oltre il 70% della soia è destinato agli allevamenti
intensivi, quelli - per essere chiari - che dipendono per
l'alimentazione del loro bestiame da prodotti non ottenuti in
azienda o
nel territorio. La soia è una delle colture più legate all'uso di
diserbanti (vedi, in Argentina - il caso più eclatante e citato -,
gli
impatti sulla salute dell'uso del glifosate) e alla deforestazione
(insieme alla palma). Il suo utilizzo è crescente perché,
paradossalmente, crescono insieme i consumi di prodotti animali
(vedi
Cina) e quelli di prodotti vegan (soprattutto in Europa). La
maggior
parte della soia è destinata all'allevamento suino ma, non si può
dimenticare che anche l'allevamento da latte ne è fortemente
dipendente (come sanno bene gli allevatori che pagano la soia il
40%
più del periodo pre-Covid). Base dell'alimentazione dei maiali e
delle
vacche che producono i "vanti del made in Italy", i prodotti dop
quali
i grana e i prosciutti crudi, sono il mais e la soia. E se la soia
produce i suoi impatti negativi oltremare, il mais, seppure
oggi largamente importato (quando sino a vent'anni fa eravano
autosufficienti), i suoi impatti li esplica qui da noi. E non sono
leggeri. L'ultimo rapporto Ispra sulla qualità delle acque dei
nostri
fiumi indica che la situazione non migliora. La presenza di
pesticidi,
oltre i limiti di legge, è da imputare alle monocolture del mais e
del
riso (pianura padana), ma, non dimentichiamolo in clima di caccia
alle streghe contro le produzioni animali, anche alla viticoltura
e alla melicoltura
(Trentino-Südtirol).

Indubbio è quindi il forte intreccio
dell'agricoltura (e dell'allevamwnto) con il sistema di quelle
multinazionali che stanno
operando la sostituzione dei prodotti di origine animale con
quelli
vegetali (un sistema che unisce "vecchie conoscenze" con nuovi
attori).
Non solo perché una materia prima come la soia è la stessa dei
prodotti
vegan ma anche perché l'industria che trasforma il latte europeo e
che
lavora le carni sta essa stessa acquistando marchi del settore
della
finta carne e del finto latte. Non solo Nestlè, ma anche i
principali
player europei del settore, stanno investendo nel finto latte e
nei finti
latticini. Uniliver, Kraft e Nestlè ma anche, per
venire a marchi a noi noti, Danone, Lactalis, Granarolo.
Buona
parte del latte italiano viene conferito a marchi che già stanno
operando nel settore antagonista al latte (e alla carne). Essere
nelle
mani dell'industria e delle multinazionali non è rassicurante per
i
nostri allevatori. Essi dipendono da un sistema largamente
governato
dalle multinazionali, sia per l'approvvigionamento di mezzi
tecnici che
per lo sbocco dei prodotti. Come si fa a dormire sonni tranquilli
sul futuro? Incorporato entro filiere agroindustriali,
l'allevamento "intensivo" (non è poi una parolaccia e si può
intendere in tanti modi) si è evoluto sotto la spinta di
prezzi sempre
più vili del latte e della carne, mentre il rapporto tra questi
prezzi
e quelli delle attrezzature, dei mangimi, e dei fitofarmaci (per
non offendere troppo coloro che si offendono e indignano a
hiamarli con un nome che incute, giustamente, sospetto e paura) è
andato sempre peggiorando, sino all'ultima impennata del prezzo
della soia e dei
cereali. Per reggere si sono ampliate le aziende (quelle scomparse
non sono più lì a lamentarsi), intensificata la
produzione, adottate tecniche e attrezzature per operare in tempi
sempre più veloci, con capacità operative e potenze sempre
maggiori.
Una rincorsa inutile perché il rapporto tra prezzi dei prodotti e
dei
mezzi tecnici continua a peggiorare in quanto è l'industria ad
avvantaggiarsi dell'aumento di produttività con il graduale
peggioramento anche del rapporto tra prezzo pagato al produttore
agricolo e quello del prodotto alimentare al consumo. L'immagine
può
essere quella di un limone spremuto, che poi viene gettato.
Quanto più le multinazionali spostano il loro business verso
(pseudo) produzioni "amiche del clima", quanto meno esse saranno
disposte a tutelare - per il proprio interesse -, con il peso del
loro
potere di lobbying, il settore della produzione animale dagli
attacchi
dell'ambientalismo che già ora preme per una pesante tassazione
dei
prodotti animali per favorire il finto latte e la finta carne.
Troppo sono poi gli intrecci tra interessi agricoli
(o di chi li rappresenta) e quelli industriali per sperare in
un'efficace difesa dell'agricoltura. In che direzione deve
allora muoversi per sfuggire alla morsa tra ambientalismo
e il sistema delle multinazionali dell'agrofood entro la quale
rischia
di restare stritolata? Con il rischio che esso appaia un mero
slogan,
ma con il proposito di fornire qualche elemento che lo sostanzi di
contentuti, osiamo asserire: "Con l'alleanza rurale!".
Presupposto dell'alleanza: ripristinare
lo spazio rurale,
annullato nella morsa tra parchizzazione, cementificazione,
agricoltura
industralizzata
Un primo punto fermo, da chiarire subito, riguarda la condizione
di esistenza della realtà
rurale che non può prescidere dalla presenza di un'agricoltura che
produce cibo e alimenta filiere locali di trasformazione e consumo
(pur
potendo esportare parte del prodotto e pur potendo produrre, come
anche un tempo, prodotti no food). Una landa di chilometri
quadrati
spianata al laser non è "paesaggio rurale", non appartiene
allo "spazio rurale". La
differenza tra le lande dell'agricoltura industrializzata e la
campagna
è la compresenza, insieme alla funzione di produzione edi
trasformazione
di alimenti, di una componente residenziale. Se un paesaggio
ameno,
popolato di seconde case o ville non è più campagna, non lo è
nemmeno il territorio sodomizzato da un'agricoltura
industrializzata, che
scaccia letteralmente gli abitanti per l'invivibilità delle
condizioni
che si vengono a determinare. Non sono solo le maxi porcilaie da
100
mila suini, le aziende bioenergetiche (cammuffate da agricole) per
la
produzione di biogas, le irrorazioni di liquami che inducono a
scappare
dalla (ex)campagna. Eh no, ancora una volta la caccia alle streghe
contro le produzioni animali non deve far dimenticare che le
monocolture insostenibili sono anche quelle della produzione
vegetale.

Oltre agli inconvenienti delle maxi porcilaie vi sono anche le
derive dei pesticidi (che fanno peggio alla salute, anche se va
ricordato che nelle esalazioni di liquami e vasconi non c'è solo
l'odore ma prodotti volatili tossici). Come nel caso delle colline
del prosecco, una produzione insostenibile non solo per il largo
uso di
fitofarmaci, ma anche per le sistemazioni del terreno, i sistemi
di lavorazione e il diserbo (glifosate) dei filari che provocano
l'erosione. Uno studio
dell'Università di Padova ammonisce che ogni bottiglia stappata
dell'eccellenza della viticoltura veneta comporta la perdita di 4
kg di terra.
La vita rurale era caratterizzata da una multifunzionalità
implicita: essa garantiva l'espletamento di tante attività,
alcune lavorative, altre al tempo stesso utilitaristiche e
di
"svago". Così per le raccolte (funghi, piante commestibili)
e le
attività para-venatorie (piccoli animali, archetti per gli
uccelli) e per la stessa caccia e pesca. Alle attività agricole
erano
connesse diverse attività artigianali (fabbri, falegnami, bottai,
carradori, casari, mugnai, frantoiani). L'agricoltura
industrializzata ha comportato una drastica riduzione di queste
attività. Filari, siepi, boschetti, stagni, piccole aree
umide
creavano un mosaico che favoriva la presenza di fauna
selvatica terrestre,, di avifauna e di ittiofauna.
L'uso massiccio dei pesticidi, nonché l'eliminazione delle
"bordure",
l'estensione a dismisura della dimensione dei campi, l'utilizzo di
potenti e veloci
macchine agricole e dei loro organi in movimento hanno contribuito
direttamente (animali arrotati) o indirettamente (mancanza di
rifugi, mancanza di risorse
alimentari come gli insetti per la nutrizione degli uccelli) a
fare un deserto dove furoreggiano i nocivi opportunisti che
regnano su un territorio degradato e impoverito come nutrie e
corvidi (gazza ladra e cornacchia grigia che hanno sterminato i
passeracei). Sono
cambiati anche i tempi e i ritmi delle lavorazioni, il tipo di
residui
colturali lasciati in campo. Sono diminuiti i prati stabili. Il
risultato è un territorio che non consente la riproduzione di
uccelli e
mammiferi e la conseguente necessità del rilascio di selvaggina
"pronta caccia"
all'apertura della stagione che fa scadere non poco l'attività
venatoria (vedasi i poveri fagiani che paiono dei polli pronti a
farsi prendere con le mani) . Bastano questi pochi accenni per
capire come la possibilità di alleanza tra mondo agricolo e
venatorio,
una delle componenti chiave dell'alleanza rurale, può essere
possibile solo se,
da entrambe le parti, si intende riconsiderare la propria
attività.

Il mondo agricolo è esasperato dall'insostenibilità dei danni
provocati dai cinghiali che, con buona ragione, attribuisce ai
cacciatori i quali, in troppe zone e occasioni, come ampiamente
documentato, hanno immesso cinghiali o
scrofe domestiche nell'ambiente. Non solo ma non si assoggettano
facilmente
alle politiche di eradicazione (risparmiando le scrofe e riducendo
il
prelievo potenzialmente possibile). Ai cacciatori si può anche
chiedere
che prendano in considerazione una riforma che li coinvolga
maggiormente nella gestione del territorio, superando
l'anacronismo
della selvaggina "patrimonio indisponibile dello stato" per
assegnarne
la proprietà ad associazioni territoriali (da non confondere con
le riserve private) formate dai proprietari e conduttori dei
terreni e dai
cacciatori. Il riconoscimento alla parte agricola il diritto a
ricavare
(in forma consortile e associata con i cacciatori) un frutto dalla
selvaggina rappresenta uno stimolo a cambiare rotta, a rivedere
l'orientamento industrializzato dell'attività agricola, a
ripristinare
la campagna, la multifunzionalità. Purtroppo appena si accena a
questi ragionamenti, che porebbero su solide basi l'allenza
agrovenatoria, le associazioni e i singoli cacciatori si
abbandonano alla demagogia: "volete la caccia solo per i ricchi".
Non è così. Ma se non si capisce che l'ambientalismo non
perderà occasione per mettere sempre più bastoni tra le ruote
all'attività venatoria e che solo l'alleanza con il mondo agricolo
può creare un fronte di resistenza forte si merita di andare a
casa.
Cambiare rotta, per esempio rivedendo il razionamento a base di
trinciato di mais e mangimi proteici a base di soia a favore del
ripristino dei prati permanenti, delle rotazioni degli erbai
poliennali
(medicai ecc.), ripristinando anche siepi, filari, stagni,
significa al tempo stesso sottrarsi al circolo vizioso
che l'industria impone all'azienda agricola (prezzi calanti, nuove
tecnologie, aumento compulsivo della produttività (per vacca, per
ettaro, per ora di lavoro) e creare opportunità di alleanza con il
mondo venatorio ma anche il cittadino che cerca occasioni
ricreative e la componente meno ideologica del mondo
ambientalista. Consente, staccando il piede dal pedale
dell'accelleratore, di valorizzare i reimpieghi, di ri-attivare
attività e funzioni rurali un tempo già svolte in ambito agricolo:
non solo trasformazione dei
prodotti, in azienda o presso laboratori "di paese", ma anche
funzioni
abitative o turistiche, ricreative, venatorie (da estendere a una
generalità di aziende e non solo a riserve e agriturismi).
Prodotti più amici dell'ecosistema (di
quelli vegan e pseudo eco)
Lo sbocco locale della produzione può certo trarre incentivo da
un ripristino della qualità della campagna che, a sua volta può,
anche riattivando la trasformazione artigianale, contribuire a
fare rinascere - anche nelle lande ora abbruttite dalle
monocolture intensive - le osterie di campagna (quelle vere, non
le parodie per milanesi) una componente essenziale eun nodo
importantissimo della vita rurale. Lo stesso vale per i piccoli
negozi che, insieme ai laboratori artigianali di trasformazione e
alle osterie posssono ricreare un tessuto rurale credibile. Tutto
ciò non può ovviamente rappresentare l'unica
soluzione per lo sbocco della produzione. Si deve aggiungere uno
sviluppo della filiera corta che riesca a collegarsi con i
mercati cittadini (mercati contadini, gas, abbonamenti spesa,
spesa a
domicilio). Ma tutto ciò non basta. Si tratta di entrare nei
mercati con prodotti che rispondano a quelle esigenze del
consumatore che, in modo distorto, l'industria intende soddisfare
con i finti latticini e la dinta carne. Le stesse grandi industrie
del settore lattiero-caseario si
stanno rendendo conto che la risposta al "non latte" e al
"non yoghurt" è l'offerta al
consumatore di prodotti che, sul piano nutrizionale ma anche su
quello
dell'impatto ecologico, risultino superiori ai "succedanei" vegan.
Non
si riuscirà a convincere i vegani militanti, che rifiutano anche i
prodotti degli animali allevati nel modo più amorevole, che godono
della piena libertà di esprimere il proprio comportamento
specifico,
che contribuiscono alla biodiversità, alle funzioni ecosistemiche
dell'agricoltura ecc. ecc., però si potrà fare breccia su chi
intende
l'ecologia non come una religione dogmatica e arcigna ma qualcosa
da verificare senza
pregiudizi. Nel post precedente (qui)
abbiamo
messo in evidenza come l'allevamento animale, favorendo la
fertilità
naturale, sia attraverso la produzione di concime organico che
attraverso l'alimentazione a base di foraggi di prati e di
pascolo, può
favorire a ridurre gli impatti climalteranti, specie attraverso il
ripristino di quella dotazione di sostanza organica che
l'agricoltura
industrializzata, con l'eccesso di lavorazioni del terreno, la
costipazione del suolo, l'uso di concimi chimici e pesticidi, ha
dilapidato.
Dobbiamo farlo non solo per stoccare CO2 (che nell'humus del suolo
di
una prateria può essere immobilizzato molto più a lungo che nel
soprassuolo
forestale) ma per ridurre il fenomeno erosivo che l'agricoltura
industrializzata ha reso grave, per ripristinare le capacità del
terreno agrario, riportando una ricca vita biologica di nutrire e
proteggere le piante, di accumulare acqua, di detossificare e
depurare.

Oggi, ascoltando gli interessi industriali che la vogliono tenere
in
pugno (fino a quando la daranno in pasto all'ambientalismo come
vittima
sacrificale), la zootecnia e l'agricoltura tutta non riescono a
concepire uno scenario diverso, a capire che quello spazio che si
apre
per prodotti percepiti (si sottolinea percepiti) come più amici
dell'ambiente può essere colmato, con prodotti realmente
ecologici,
dalla zootecnia e dall'agricoltura stesse. Se cambiano rotta, se
si
staccano dal giogo industriale che, per esempio, porta le
organizzazioni agricole svizzere (nonostante la forte diffusione
dell'agricoltura biologica in Svizzera con oltre il 10% del
fatturato
alimentare e il 16% della superficie agricola) a difendere in modo
accanito i pesticidi, ovvero la dipendenza all'industria chimica
(in
Svizzera c'è Novartis, guarda caso). Non c'è dubbio che la
transizione a
un'agricoltura senza pesticidi di sintesi non può che essere
graduale.
I sistemi agricoli si sono modellati sull'utilizzo di pesticidi e
concimi chimici (a partire dalle varietà coltivate) e sono
necessarie
forti misure di sostegno per un passaggio ad un sistema senza
fitofarmaci. Ma vedere le organizzazioni agricole fare campagna
pro
pesticidi, allendosi con l'industria chimica contro il consumatore
(che,
in questo caso ha pieno diritto di dire la sua, non come nel caso
del referendum sulle modifiche alla legge sulla fauna per poter
contenere la proliferazione dei lupi) lascia l'amaro in bocca
perché significa dare argomenti all'ambientalismo e, invece di
cercare
l'alleanza, quantomeno la comprensione, del consumatore (urbano e
non) preoccupato per
la salute dell'ambiente e propria, spingerlo sulla linea
ambientalista
radicale (in tema di parchi e grandi predatori tanto per
cominciare). Ma è anche la possibilità stessa di un'alleanza
rurale, in nome di una campagna più vivibile e attrattiva che
viene resa più difficile dalla linea pro pesticidi delle
organizzazioni
agricole, mentre ci si accoda a un'industria che proma o poi
pugnalerà l'agricoltura alle spalle A Malles, in Südtirol, non
sono stati gli ecologisti da
salotto a votare a favore del referendum contro i pesticidi ma gli
abitanti rurali, che subiscono le conseguenze delle deriva dei
trattamenti "fitosanitari" ai meleti (in val Venosta monocoltura
invasiva quasi
come in val di Non).
 Un
aspetto
della campagna contro di pesticidi a Malles, val Venosta
(Bolzano)
Un
aspetto
della campagna contro di pesticidi a Malles, val Venosta
(Bolzano)
D'altra parte, l'emancipazione del produttore agricolo dalla
cultura
produttivistica, quantitativa, utilitaristica, individualista
instillata dall'industria, dalle organizzazioni agricole, dal
sistema
di consulenza pubblica e privata, dall'Università e dai centri di
sperimentazione e ricerca, non è un fatto automatico ma una
difficile conquista culturale. Non si chiede solo agli agricoltori
di
operare per il recupero di una cultura rurale che può salvarli dal
rimanere schiacciati nella morsa tra ambientalismo e
multinazionali, ma
si chiede anche ai cacciatori, ai fruitori della campagna di
riavvicinare la propria mentalità a quella rurale e di
riavvicinarsi al mondo agricolo . Lo si chiede agli abitanti dei
piccoli centri che si
lamentano per la vicinanza di una stalla, che magari ha una
concimaia
"tradizionale" che profuma di buon letame (e che non si rendono
conto quanto
la pulizia dell'industria, la mania dei disinfettanti, nascondano
lo
sporco chimico, quello dalle conseguenze subdole). Si richiede un
recupero di cultura rurale al consumatore (urbano e no) che chiede
prodotti artigianali e genuini, ma poi si lamenta se non sono
sempre uguali a sé stessi, se presentano qualche difformità
estetica, non
capendo che la produzione su piccola scala, con tecniche e
attrezzature
artigianali si adatta alle condizioni cangianti dell'ambiente ed è
esposta a fattori contingenti che non sfiorano la grande industra
alimentare.
L'alleanza rurale presuppone il dialogo tra le sue diverse
componenti,
tenendo presente che la parte agricola è il cardine ma che
anch'essa
deve operare per migliorare quelle funzioni che favoriscono tutti
gli altri
attori rurali.

L'alleanza rurale non può essere una sommatoria di componenti
agricole, venatorie, turistiche, residenziali ecc. Tutte
profondamente
segnate sia dalla deruralizzazione in senso agroindustriale di
quelle
che erano le campagne che dalla falsa neo-ruralizzazione "di
consumo"
che i sociologi definiscono "gentrificazione" e che possiamo
tradurre
in linguaggio comune come il processo di trasformazione della
campagna
in un fondale scenico in grado di corrispondere ai desideri e ai
capricci
degli scappati dalla città rural-chic (vedi qui
le nostre
considerazioni sui conflitti tra gli "scappati" e il mondo rurale
autentico che, in Francia hanno portato all'approvazione di una
legge
per la tutela dei "rumori della campagna: canti di galli, campane,
muggiti, gracidare di ranocchi ecc.).
Uniti, ma se si eliminano le aberrazioni
dell'eccessiva
industrializzazione agro-zootecnica
Quando diciamo che ogni componente deve operare l'avvicinamento
alle
altre riducendo il conflitto in atto o potenziale e operando per
aumentare i fattori di incontro, ci riferiamo, vale ribadirlo,
anche alla componente
agricola. Se è vero che l'attacco ai sistemi di produzione
animale, e
più in generale a tutte le attività agricole portato avanti
dall'ambientalismo e dalle multinazionali, non risparmia
"estensivi" e
"intensivi", bio e convenzionali, piccoli e grandi, è anche
necessario
ribadire che ci sono sistemi di produzione che concorrono in modo
pesante agli impatti ambientali, al degrado del paesaggio,
all'invivibilità
della (ex)campagna, alla diffidenza del consumatore per le
produzioni
animali e vegetali. Detto questo non si può fare di ogni erba un
fascio e condannare
come insostenibili un'azienda, un comparto solo per via delle sue
dimensioni. Sia l'impatto ambientale che il benessere animali non
sono
scontati e vanno valutati nel concreto. Quindi niente "buoni" e
"cattivi" a priori. L'alleanza rurale non può non comprendere
quelle
componenti che intendono muoversi verso una logica agroecologica
anche
partendo da condizioni di partenza frutto di una generalizzata
(auto)
sottomissione economica, tecnica, culturale al sistema
agroindustriale.
Le tendenze in atto stanno trasformando quelle che sembravano
filiere
forti in nicchie, aziende grosse in aziende che fanno
fatica.

Però va rifiutata anche la linea "tutti i gatti di notte sono
grigi"
e "volemose bene", mettendo davanti come una facciata la piccola
azienda che fa pascolo e
usa prevalentemente il fieno di montagna, che si limita a
produzioni
compatibili con la realtà climatica e agronomica. Non vale
sostenenere che questa operazione è alla fine legittima
perché, "in
fondo siamo tutti uguali". La linea che "copre" sistemi che
fanno largo
uso di pesticidi e concimi chimici, che hanno eliminato la
biodiversità, ogni filare di alberi tanto per cominciare, che
praticano il diserbo
dei fossi con il glifosate, che trattano la terra in modo
talmente brutale da non far sopravvivere un lombrico non è una
linea credibile e non porta da nessuna parte. Alcuni dicono:
"facile, tanto in montagna non si può produrre di più, qui in
pianura
abbiamo costi tali che ci costringono a spingere la produzione, a
sfruttare la terra e gli animali". Ma in pianura resta comunque
più
agevole applicare la meccanizzazione, il clima e la disponibilità
di
acqua di irrigazione (dove c'è) pongono comunque meno vincoli che
in
montagna. Restare inchiodati (salvo quel tanto imposto dalla
condizionalità Pac) alla monocoltura del mais (da triciato o
pastone) è
miope. A ruota di Mila (Bolzano), che per prima ha lanciato il
latte-fieno (più ricco di omega-3 e acido linoleico coniugato ma
non
solo) anche altre aziende (per esempio la latteria Soligo che
raccoglie latte
nella montagna veneta) hanno seguito l'opportunità di utilizzare
la
certificazione europea STG (Specialità tradizionale garantita)
che,
meno nota delle DOP e IGP, rappresenta una compensazione (peraltro
non
nuova) per le tante mosse di Bruxelles, a favore delle
multinazionali.
A produrre latte-fieno è arrivata anche Granarolo, che non
raccoglie
latte sui masi. Anche in pianura si può recuperare sostenibilità
dei
sistemi agrozootecnici, rinunciare alle concentrazioni aberranti
(diverse volte tanto quelle concesse dalla direttiva nitrati eluse
con
deroghe varie). Non ha senso parlare di agroecologia e ammettere
che
certe, mentre in certe aree della bassa Lombardia interi territori
scoppino di Uba, con mega allevamenti suini e
stalle da duemila vacche da latte (che poi devono ricorre a
"rimedi"
come il biogas che rischiano di creare nuovi problemi) le
monocolture viticole e ulivicole in intere regioni del centro-sud
facciano il "deserto zootecnico", esponendo il suolo agrario, già
povero di
sostanza organica per via del clima, alla desertificazione.
Da decenni si fanno progetti sulla produzione di proteine vegetali
e
rotazioni in alternativa alla razione soia + mais; si tratta di
passare
dalla teoria alla pratica e non possono che farlo le aziende
agricole,
senza aspettarsi chissà quali aiuti dall'alto ma creandosi, da
sole o in
collaborazione con altre aziende, degli sbocchi nuovi per i loro
prodotti (in alternativa a conferire a Lactalis e simili).
Di
certo la Ue, che
infila la sostenibilità e l'ambiente in ogni frase, potrebbe fare
di
più
(non l'ha fatto nemmeno in occasione dell'ultima "riforma") ma
questo
giustifica stare ancora fermi?
L'ambientalismo lavora, le multinazionali anche; vogliono
tagliare
l'erba sotto i piedi all'agricoltura (anche quelle che ora
comprano a
prezzi insultanti la materia prima agricola). Non perché amano sul
serio la "Natura" ma perché hanno fiutato le possibilità di
metterla in
difficoltà l'agricoltura, per i loro fini.